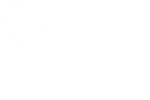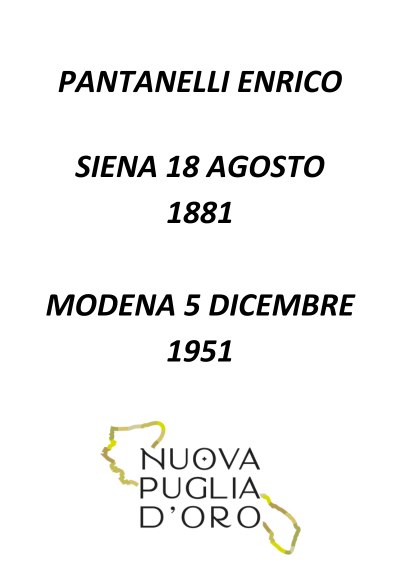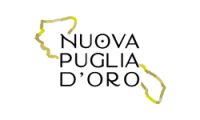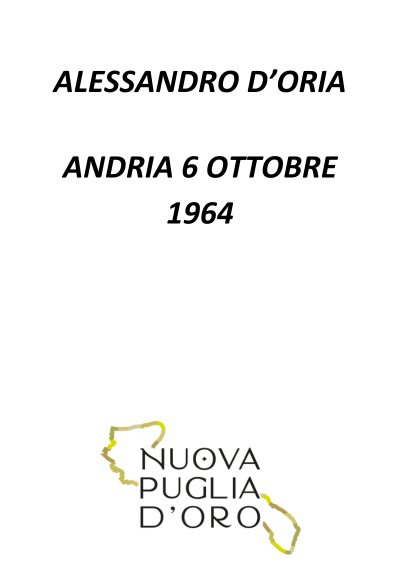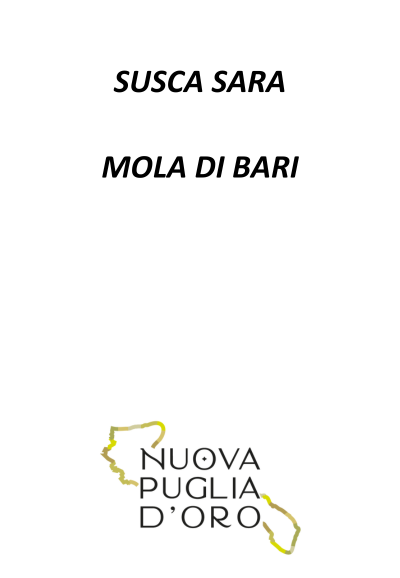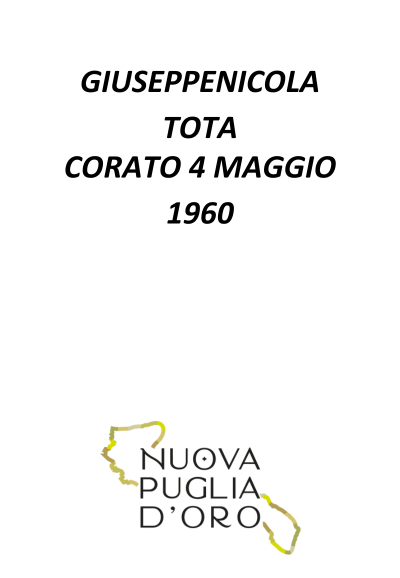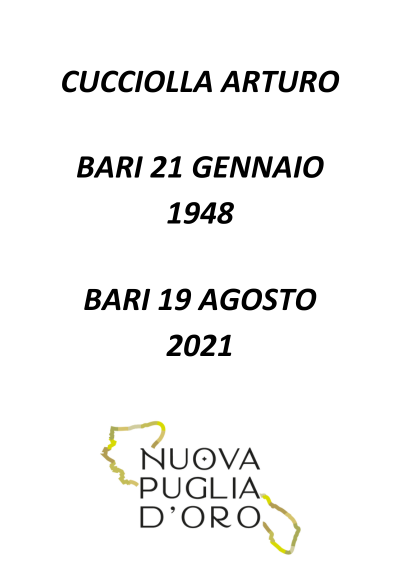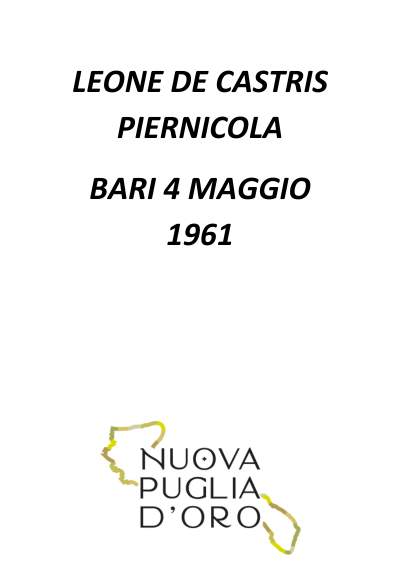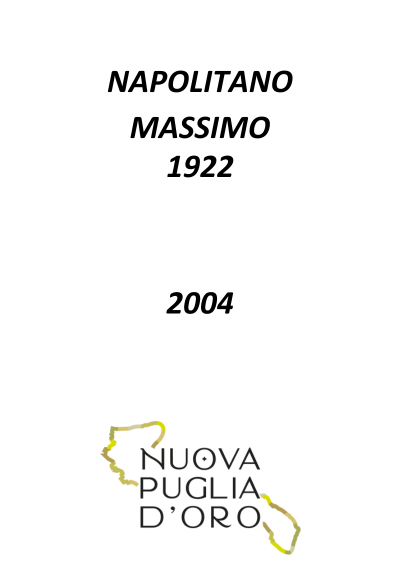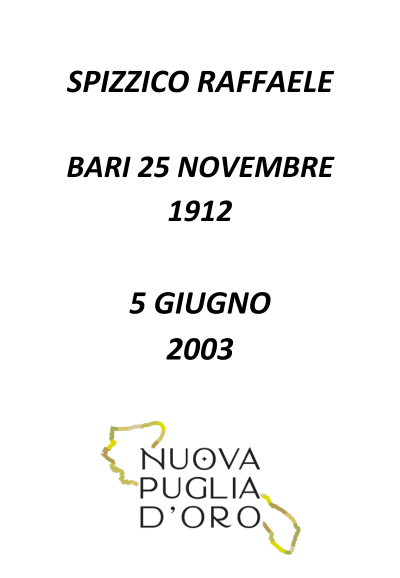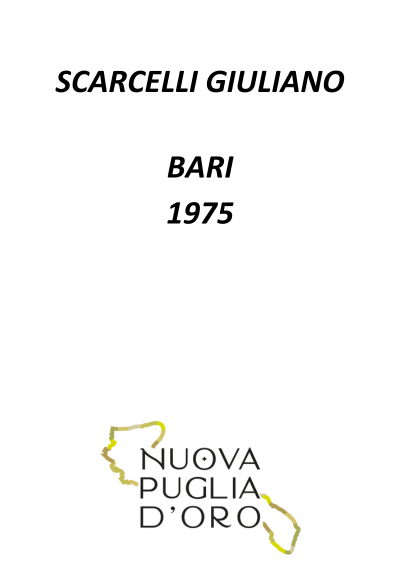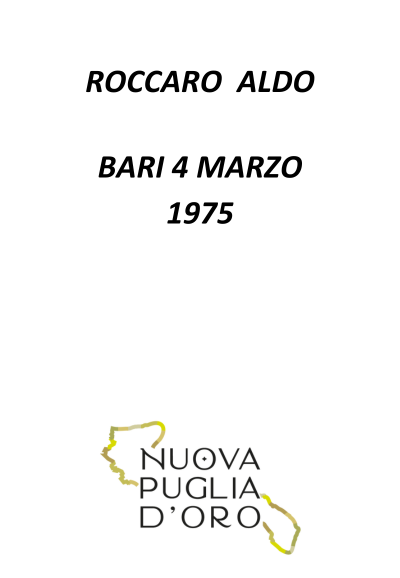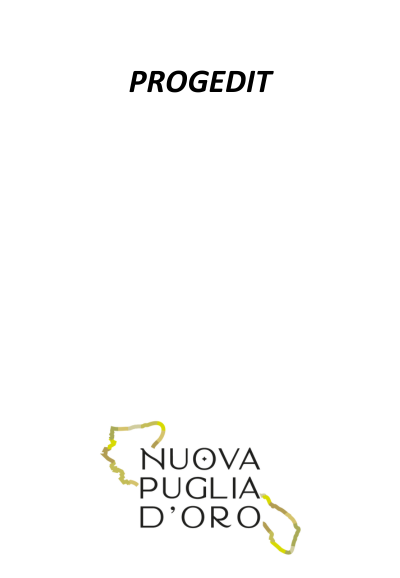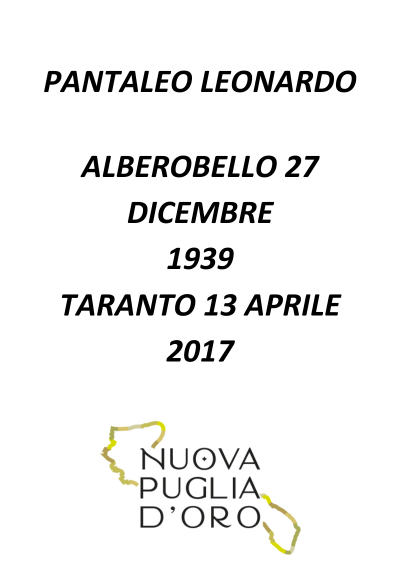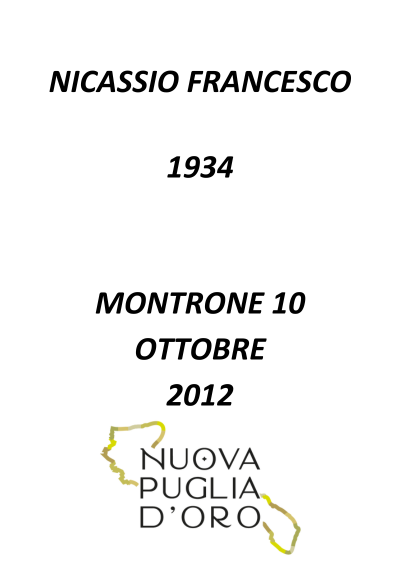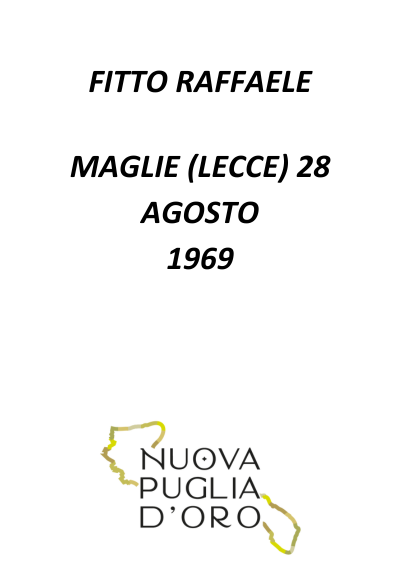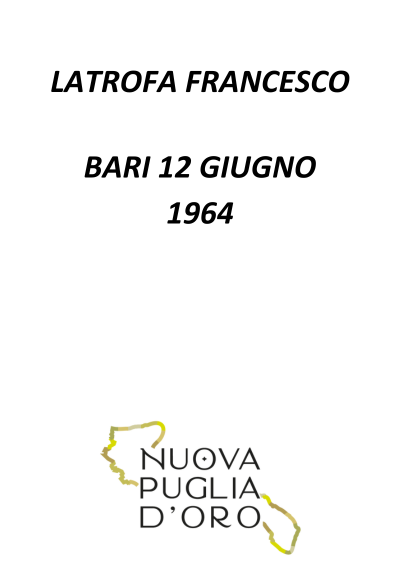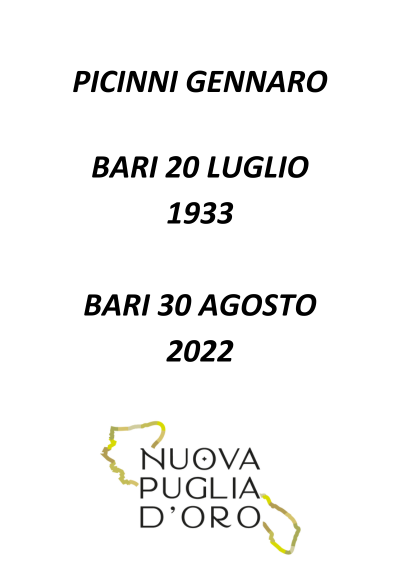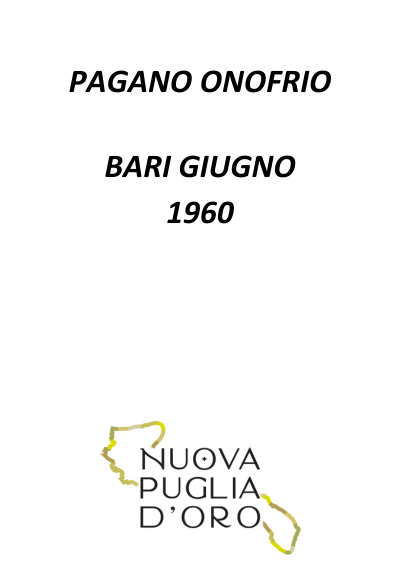Figura di studioso e maestro, Enrico Pantanelli può essere considerato il caposcuola dell’agronomia “scientifica” pugliese. Nato a Siena il 18 agosto 1881, si trasferì ben presto con la famiglia a Modena, presso la cui università il padre Dante aveva ricevuto l’incarico di insegnare Geologia. Fin da piccolo, amava aiutare il genitore nel laboratorio e seguirlo nelle ricerche: tali esperienze suscitarono in lui un profondo interesse per lo studio della natura.
A ventun anni conseguì la laurea in Scienze Naturali; vincitore di una borsa di studio, ebbe la possibilità di frequentare numerosi laboratori all’estero, perfezionandosi, tra l’altro, sotto la guida del Premio Nobel Wilhelm Ostwald (1853-1932) a Lipsia. Cominciò inoltre ad interessarsi a problematiche scientifiche correlate all’agricoltura presso la Scuola Superiore di Agricoltura di Berlino e la Scuola di Pomologia e Viticoltura di Geisenheim sul Reno.
Tornato in patria, mise a frutto l’esperienza accumulata nei laboratori di Svizzera e Germania, per cercare di fornire un contributo agli studi di fisiologia vegetale, la quale in Italia si trovava in una situazione di penalizzante arretratezza. Appartengono a questo periodo le ricerche sulle Zigofillacee (famiglia di piante Dicotiledoni, proprie delle regioni a clima caldo, le quali forniscono legni pregiati, resine e sostanze coloranti), sull’albinismo, sulla fotosintesi, sul turgore cellulare e sull’accrescimento delle muffe.
Nel 1905 conseguì la libera docenza in Botanica; dal 1906 al 1913 fu assistente alla Stazione di Patologia vegetale di Roma, diretta da Giuseppe Cubani (1857-1920). Intanto, avido di conoscenze, conseguì una seconda laurea, in Chimica, a Roma (1908) sotto la guida di Stanislao Cannizzaro (1826-1910) ed Emanuele Paternò (1847-1935). Risultato della sua prima attività di chimico furono i lavori sui sali complessi del titanio, sugli aminoacidi e gli enzimi.
L’eco delle sue ricerche iniziò a diffondersi. Chiamato a Napoli come aiuto di Fridiano Cavara (1857-1929) all’Istituto Botanico, con l’incarico di riorganizzare il settore fisiopatologico, lavorò contemporaneamente alla Stazione Zoologica, fino a quando venne nominato ispettore presso il Ministero dell’Agricoltura (1914-21). Certo, gli impegni istituzionali sottraevano tempo alla passione per la ricerca, tuttavia l’incarico gli dette l’opportunità di visitare e conoscere da vicino le condizioni dell’agricoltura italiana, soprattutto nel Mezzogiorno. Così, quando nel 1921 venne nominato direttore della Stazione Agraria Sperimentale di Bari, Pantanelli era già consapevole dei problemi della regione e aveva già riflettuto sul modo in cui affrontarli.
Pur non essendo ancora un agronomo, egli aveva certamente le carte in regola per diventarlo: cultore di geologia e chimica, autorità nel campo della fisiologia e della patologia vegetale, sperimentatore acuto, si dedicò all’ecologia agraria, in particolare allo studio dei rapporti tra clima, vegetazione e produzione agricola in Puglia. Le norme colturali da lui sperimentate, accanto al criterio del graduale spostamento, nei periodi più propizi, delle date di semina e coltivazione, ebbero come risultato l’incremento della produzione e della qualità dei raccolti. Sempre nella veste dello sperimentatore, si occupò dei problemi connessi all’attività foraggiera in Puglia: a lui si deve la costruzione, nel 1924, del primo silo da foraggio della regione. Proprio i successi conseguiti in questo campo attirarono Pantanelli nell’orbita delle iniziative operanti, in quegli anni di pionieristico entusiasmo, la trasformazione agraria del Mezzogiorno.
L’intensa attività sperimentale di Pantanelli suscitò l’attenzione di molti atenei italiani, primo tra tutti quello di Pisa, dalla cui Facoltà di Agraria venne chiamato a insegnare (dal ’31 al ’37) Tecnica della bonifica. Numerose furono le accademie che lo accolsero tra i propri membri: tra esse, l’Accademia delle Scienze Fisiche e Naturali di Napoli nonché il corrispettivo di Modena, la Deutsche Botanische Gesellschaft, la Société Nationale des Microbiologistes di Nancy, l’American Society of Plant Physiologists di Philadelphia.
Nonostante gli innumerevoli impegni accademici, l’attività scientifica e divulgativa di Pantanelli non conobbe battute d’arresto. Sollecitato ad occuparsi della nascente Facoltà di Agraria a Bari, nel ’41 gli fu affidato l’insegnamento di Agronomia e coltivazioni erbacee. Tre anni dopo venne nominato Preside della Facoltà, ma fu l’incarico di Patologia vegetale, che egli coprì dal ’45, ad appassionarlo in modo particolare. In proposito si ricordano numerosi contributi: dal lavoro sull’arricciamento della vite alle ricerche sui meccanismi di resistenza al freddo nei vegetali. In questo periodo – e saltuariamente anche in seguito – si occupò di anticrittogamici, pompe irroratrici ed infine di genetica vegetale.
L’approccio di Pantanelli fu sempre di tipo “olistico”, lontano dal riduzionismo imperante nei laboratori tedeschi; alle scienze dure, chimica e fisica, l’eclettico osservatore associò uno studio complessivo dell’ambiente della regione, dal punto di vista ecologico, sociale ed economico. L’elenco delle sue pubblicazioni presenta negli anni un graduale spostamento di interesse dalle scienze pure a quelle applicate, dalla chimica e dalla fisiologia alla patologia vegetale e a processi delle industrie agrarie, quindi al vasto campo dell’agronomia e delle coltivazioni, in particolare erbacee.
Egli applicò la sua esperienza di agronomo, ad esempio, nell’organizzazione dell’Azienda “S. Chiara” della S.E.B.I. ad Ofantino, dell’Azienda “Rosario” dei fratelli Motolese a Grottaglie e di quella dell’Istituto Agrario di Capitanata a Foggia, contribuendo inoltre all’elaborazione del primo piano di trasformazione fondiaria del Tavoliere. Nel campo più specificamente agronomico, pubblicò una serie di studi sulle concimazioni azotata, fosfatica ed organica, sull’impiego del ferro, sulle risorse idriche di Puglia, Lucania e Pirenaica, sull’uso delle acque salmastre, sul maggese a rotazione, sulla semina e sull’aridocoltura.
La competenza in ambito chimico gli consentì di estendere l’indagine alla microbiologia del terreno, pubblicando lavori ancora oggi interessanti, sulla fillossera, sui thrips e sulla mosca olearia. Tra gli studi di chimica del terreno si ricordano quelli sulla composizione delle acque freatiche sfruttabili per l’irrigazione e gli studi chimico-agrari sui terreni della Provincia di Bari e del Tavoliere delle Puglie.
Durante gli ultimi anni di vita, avvertì fortemente la necessità di riordinare la Facoltà di Agraria, di seguirla nel processo di rinnovamento che egli stesso aveva contribuito ad avviare. Un male implacabile pose fine, in breve tempo, alla sua esistenza in un ospedale di Modena il 5 dicembre del 1951.
Filomena Calabrese Rossella De Ceglie
Da Scienziati di Puglia (a cura di) Francesco Paolo de Ceglia Adda Editore, 2007 pag. 469-470
Cenni bibliografici
Letteratura primaria:
Osservazioni sulla composizione di alcune acque freatiche del Tavoliere, Laterza, Bari 1926.
Problemi agronomici della bonifica integrale, Barbera, Firenze 1936.
[con U. Boccassini e V. Brandonisio] Studio chimico agrario dei terreni della Provincia di Bari, Stazione Agraria Sperimentale, Bari 1937.
Coltivazioni erbacee, Macrì, Bari 1942.
Problemi agronomici del Mezzogiorno, Ed. Agricole, Bologna 1950.
Agronomia generale, Ed. Agricole, Bologna 1962.
Letteratura secondaria:
Bottini O., Enrico Pantanelli, «Annali Facoltà Agraria», 8 (1953), pp. 7-13.
D’Antone L., Scienze e governo del territorio. Medici, ingegneri, agronomi e urbanisti nel Tavoliere di Puglia (1865-1965), F. Angeli, Milano 1990, passim.
De Robertis A., La Stazione Agraria Sperimentale di Bari. 50 anni di attività a favore dell’Agricoltura meridionale, 1st. Sup. Agr., Bari 1968.
Questo XVI volume degli Annali della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, dedicato alla memoria di ENRICO Pantarelli, di cui quest’anno ricorre il decennale della morte.
Questa Facoltà che, ai suoi inizi da Lui soprattutto fu animata, cui Egli dette subito lustro col Suo nome di uomo integerrimo e di studioso di risonanza internazionale, questa Facoltà crede che il ricordarLo con il lavoro di oggi sia il modo migliore di onorarLo, quale che a Lui, schivo e lontano da ogni espressione che sapesse in qualche modo di retorica, più sarebbe piaciuto.
Dieci anni fà, il 5 dicembre 1951, a Manarello in provincia di Modena, tra il rimpianto di quanti ne avevano ammirato la dottrina e le opere e di tutti coloro che il Suo insegnamento aveva formato, cessava di vivere Enrico Pantanelli cui tanto debbono la ricerca fondamentale, quella applicata alla vita delle piante e l’agricoltura meridionale in genere…
Nato a Siena il 18 agosto 1881 e trasferitosi presto a Modena dove aveva compiuto i suoi studi, sin dalla sua fanciullezza, « sticciando», come Egli diceva nel laboratorio di suo padre Dante, insigne geologo e professore nel locale Ateneo, Enrico Pantanelli
si applicò con tutto il suo giovanile entusiasmo, a problemi di ricerca scientifica, quella ricerca che fu, in fondo, la costante grande passione della sua vita. Conseguita a Modena alla età di 21 anni la laurea in Scienze naturali, successivamente, con una borsa di studio triennale del Ministero della Pubblica Istruzione, frequentò attivamente numerosi laboratori esteri, e ivi si perfezionò sotto la guida di insigni Maestri quali Pfeffer, Ostwald, Beckmann, Schulze, Burri, Fischer, Sorauer. E in quell’epoca, presso la Scuola superiore di agricoltura di Berlino e la Scuola di pomologia e viticoltura di Geisenheim sul Reno, cominciò anche a interessarsi ai
primi problemi applicati all’agricoltura. Nel 1908 conseguì anche la laurea in chimica sotto l’alta scuola di Cannizzaro e Paternò.
Libero docente di Botanica sin dal 1905, fu assistente alla Stazione di Patologia vegetale di Roma, diretta dal Cuboni (1906-1913) e tenne all’Università di Roma un corso di Fisiologia vegetale.
Passò poi a Napoli come aiuto in quell’Istituto botanico, dove sostituì temporaneamente il Cavara e lavorò presso la locale Stazione zoologica. Dal 1914 a tutto il 1921 prestò la sua opera come ispettore presso il Ministero dell’Agricoltura, provvedendo alla riorganizzazione del servizio fitopatologico; a questo periodo, che lo distolse dalla sua attività di ricerca, Egli guardò spesso con rammarico, anche se il nuovo compito gli permise di conoscere più da vicino l’agricoltura italiana e specialmente il Mezzogiorno e le Isole.
La sua produzione scientifica, tuttavia, pure in quegli anni non mostrò pause , anche per la preziosa collaborazione e la silenziosa dedizione della consorte, la signora Giovanardi Pantanelli. Dal 1922, avendo vinto il concorso per Diretpre della Stazione sperimentale agraria di Bari, pasto rimasto vacante per la prematura morte di Celso Ulpiani,
Fondata poi a Bari la Facoltà di Agraria gli fu attribuito dal 1039 l’incarico agronomia e coltivazione erbacee e dal 1945 anche quello di Patologia vegetale.
Nel 1941,senza concorso, per chiara fama, fu nominato professore onorario di Agronomia e fu chiamato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Bari; manteneva però ancora, per incarico, la Direzione della Stazione Agraria, che lasciò nel 1947.
Nel 1944 fu eletto e successivamente confermato, Preside della Facoltà di Agraria.
Il terribile male, che inesorabilmente lo colse, gli stroncò la vita mentre si accingeva
ancora in pieno fervore di lavoro, a darci alcune sintesi conclusive della sua infaticabile opera di studioso, le quali avrebbero dato a noi tutti, nei più diversi
campi della biologia vegetale, la possibilità di avvalerci di tanta esperienza da lui accumulata nella sua lunga attività.
La produzione scientifica di Enrico Pantanelli è un valido indice della sua levatura di Uomo e di Scienziato, La cultura vastissima, la ferrea memoria, l’ardente Passione per la ricerca, la volontà tenace, l’eccezionale resistenza ad un intenso lavoro, gli consentirono di addentrarsi in tutti i campi, nei quali una questione insoluta gli si presentasse, Un’avida sete di nuove conoscenze lo assillava perennemente. Impostato un problema, ne affrontava un altro e poi un altro ancora; e sempre così, con lo appassionato spirito ed il geniale intuito dei latini e con la scorta singolari componenti del suo carattere.
Enrico Pantanelli aveva la tempra del Pioniere. Solitario ed ecclettico osservatore, Egli sentiva degli il] fascino dell’ambiente nuovo, aspetti inesplorati delle cose. Per questo la sua produzione centotrentasei pubblicazioni ed impossibile riferire sulle numerosissime esperienze inedite di cui Egli solo avrebbe potuto dirci e che pur chi gli stava vicino sentì solo occasionalmente e per sommi capi ricordare da Lui.
La sua produzione presenta uno spostamento graduale ma costante dalle scienze pure, che gli servirono di solida base, alle scienze applicate; dalla fisiologia vegetale e dalla chimica, alla patologia vegetale ed alle industrie agrarie ed infine al vasto campo dell’agronomia e delle coltivazioni, particolarmente di quelle erbacee.
Tornato in Italia, quando gli studi di fisiologia vegetale non vi erano ancora sviluppati come in altri Paesi, Egli vi recò l’ap- Porto di quanta dottrina ed esperienza aveva accumulato nei la- boratori di Svizzera e di Germania. Sono di questo periodo gli studi sulle zigofillacee, sui pulvini motori, sull’albinismo, sulla fotosintesi, sulla respirazione, sul turgore cellulare, sull’accresci- mento delle muffe, sull’assorbimento radicale.
Traccia della sua prima attività di chimico si ha nei lavori Sui sali complessi del titanio, sugli aminoacidi, sugli enzimi. In patologia vegetale, Pantanelli lasciò chiara impronta di sè coi lavori sull’arricciamento della vite e sui meccanismi di resistenza al freddo nei vegetali. Degni di nota sono pure quelli sull’avvizzimento del cocomero, la cascola fiorale del Frappato, il cancro americano del castagno, le gommosi, l’oidio della quercia, le alterazioni del legno, le malattie dell’olmo, la fersa del gelso, la peronospora della vite, le ruggini. In questo periodo, e saltuariamente anche dopo, si occupò anche di anticrittogamici, di pompe irroratrici, di selezione di piante resistenti, Si interessò anche di microbiologia del terreno, allorchè affrontò lo studio della microfora dei terreni libici. E, insieme a essi, pubblicò la- vori, sempre originali, ancor Oggi interessanti, sulla filossera, su- gli eriofidi dell’olivo, su altre acariosi, sui Thrips, sulla mosca olearia, sulle cavallette € persino sulle arvicole.
Nel campo delle industrie agrarie esordì con studi sulla vinificazione con fermenti selezionati. Trattò poi della produzione dell’alcool] dal ficodindia, delle conserve di pomodoro, dei maggi for- pugliesi, della panificazione e dedicò parecchi lavori allo olivo, nei riguardi delle qualità degli olii, e all’oleificio.
Tra gli studi di chimica del terreno basterà ricordare un pò a caso quelli sul liquido circolante dei terreni libici, sulla composizione delle acque freatiche utiliabizzabili per l’irrigazione e gli studi chimico-agrari sui terreni della provincia di Bari e del
Tavoliere di Foggia.
Enrico Pantanelli tendeva a farsi un quadro completo, una esperienza personale nella regione nella quale si muoveva. Era quindi inevitabile che si occupasse di ecologia agraria e, in particolare, dei rapporti tra clima, vegetazione e produzione agraria in Puglia. E ricercò ed ottenne anche dati sull’evaporazione e sulla condensazione del vapore acqueo nei terreni pugliesi.
Nel campo più specificamente agronomico, Pantanelli ci ha lasciato una lunga serie di studi sulle concimazioni azotata, fosfatica ed organica, sull’impiego del ferro, sulle risorse idriche di Puglia, Lucania e Cirenaica, sull’impiego delle acque salmastre e su modalità e sistemi di irrigazione in Puglia, sull’influenza delle lavorazioni sul terreno, sulla stanchezza del terreno, su maggese e rotazione, sulla semina e sull’aridocoltura. Come si vede, riassumere la Sua opera di agronomo generale è quasi impossibile. Eppure, Egli trattò anche di coltivazioni speciali arboree ed erbacee (soprattutto cereali, soia e barbabietola da zucchero) e si appassionò a lungo sul problema delle foraggere nel Mezzogiorno.
Ed applicò anche quanto studiava, dandoci, per così dire, una sintesi di parte del Suo pensiero nell’organizzazione delle azien- de di S. Chiara della S.E.B.I., di Rosario dei Fratelli Motolese, del- l’Istituto agrario di Capitanata, nello studio del piano di massima della trasformazione agraria del comprensorio delle valli del Cervaro
e del Candelaro.
Una gran parte della Sua esperienza è riassunta nei volumi riferentisi alla fisiologia vegetale (1908), alle fermentazioni dei prodotti agrari (1912), ai problemi agronomici del Mezzogiorno (1950) ed in quelli di agronomia e di coltivazioni erbacee, che ap- parvero nella veste definitiva dopo la Sua morte (1952 e 1954).
Da quello che è stato fin qui detto sembra emergere chiaramente,come si è già accennato, quanto difficile sia tracciare in poche pagine un profilo di Enrico tutto Pantanelli, studioso, e soprattutto seguire attraverso gli scritti la complessa evoluzione del Suo intelletto nelle attività di ricerca e applicate.
Sì desidererebbe che Egli fosse ancora con noi, per risentirne il travaglio dello Studioso e la Sicurezza del Maestro.
Eppure, a dieci anni dalla morte, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo davvicino ricorda con reverenza, forse più ancora di queste Sue eccezionali doti di Uomo di Scienza, la Sua dirittura, la rigida nobiltà del Suo carattere, la voluta modestia della Sua vita famigliare.
Enrico Pantanelli è, in ciò, un esempio luminoso, il cui ricordo è ancora vivissimo nell’ambiente di quelli che furono i Suoi laboratori. .
E ci sia lecito, a questo proposito, finire, ricordandolo negli ultimi mesi che precedettero il Suo trapasso, allorchè, già divorato dal male e stremato nelle forze, si recava giornalmente, sotto il sole cocente dell’estate pugliese, al Suo Istituto, come se nulla di grave avvenisse in lui, o come se, meglio, Egli volesse crocianamente mostrarci che il nostro contributo alla vita va dato fino all’ultimo e che solo così è è degnamente attesa la Morte.