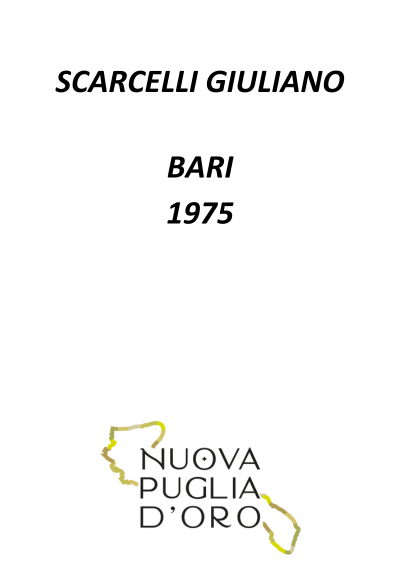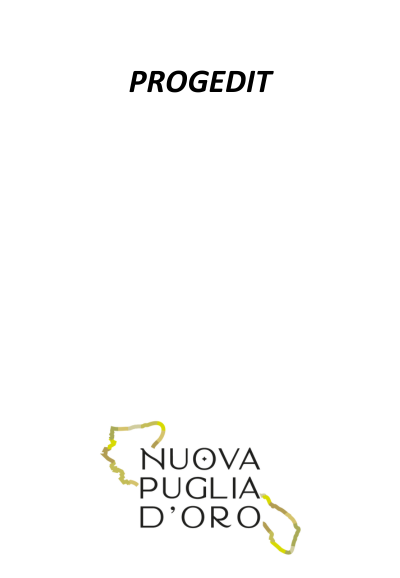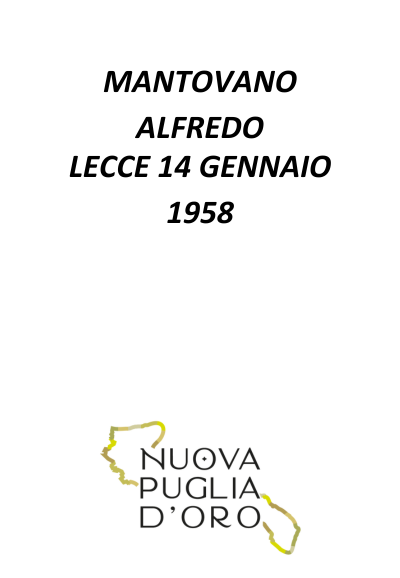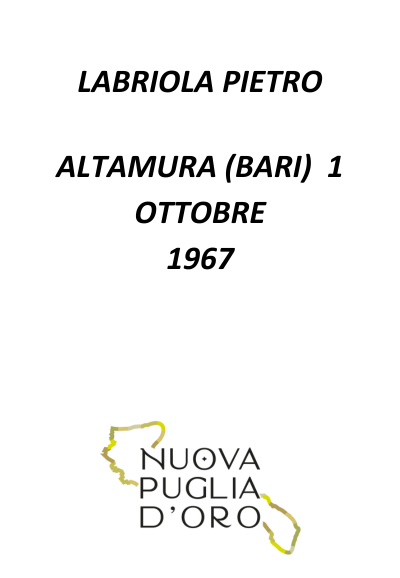Benito Gallo Maresca è uno di quei maestri del Novecento che hanno contribuito a fare più importante la pittura del Mezzogiorno e hanno dato continuità all’ impressionismo napoletano traducendolo in elementi ora nostalgici ora caricaturali. Un artista per il quale è fondamentale osservare e trasformare, perché nella trasformazione della realtà in sequenze di immagini colui che crea descrive la coesistenza nella vita della festosità e della malinconia, pratica l’osservazione del presente e la ricostruzione del passato.
Originario di Boscotrecase, in provincia di Napoli, dove era nato nel novembre 1920, si era stabilito in via Maranelli, alla periferia nord di Bari, dove aveva una casa immersa nel verde, con un doppio studio, uno al piano rialzato del condominio, l’altro in un gazebo del giardino sottostante. Come dire comodi d’estate e d’inverno in un frammento di verde nel complesso del cemento condominiale.
Veniva di frequente a farmi visita, perché abitavamo a poca distanza e ogni volta aveva una busta di limoni raccolti nel suo giardino o di ciliegie del suo fondo di Ruvo. Io ricambiavo l’affetto con l’aglianico del Vulture e con visite al suo studio o a casa, dove aveva una piccola collezione di sculture di Bibbò e di Santulli e opere di Brancaccio, di Chiancone e di Ciardo.
Molte volte ci andavo in compagnia di un amico comune, il dottor Lamorgese che Benito conosceva da anni e che aveva ritratto, in compagnia di Pina, la moglie, o del figlio. Casa Lamorgese era infatti tappezzata di opere di Benito, non solo oli e tempere ma anche schizzi e incisioni, che denunciavano un gusto maniacale dello pneumologo per l’arte di Gallo Maresca.
Ricordo il nostro ultimo incontro, ero lì per fargli visita dopo una lunga assenza, per programmare con lui e con la moglie Maria Pia, una monografia per i suoi prossimi novant’anni. Ma lui mi guardava e sorrideva, non mi aveva riconosciuto, sfogliava di continuo una rivista d’arte e si soffermava sui dipinti degli impressionisti francesi e ripeteva: “sono grandi e sono feroci. Non sono passionali?” Mi aveva sorpreso per il suo improvviso decadimento e ora per quella appassionata difesa di una corrente che era stata al centro della sua formazione di pittore. Il gatto soriano che gli faceva compagnia entrava e usciva dalla soglia del salone.
Qualcosa dei nostri anni.
Ho conosciuto Benito Gallo Maresca negli anni Ottanta. Lui era da tempo un pittore affermato, io mi occupavo di informazione televisiva e più volte descrissi la sua pittura, senza che mai mi rilasciasse interviste, perché a suo dire dovevano parlare per lui le sue opere.
Aveva fatto da tramite un poeta, Leonardo Mancino, un uomo geniale e tempestoso originario di Osimo e stabilitosi a Valenzano di Bari. Insieme avevano realizzato alcune cartelle di incisioni e poesie. Benito amava molto l’arte incisoria e realizzava almeno tre quattro cartelle all’anno per la ricca società imprenditoriale barese che in quegli anni non si era chiusa a riccio come sarebbe accaduto al passaggio del millennio. Nel 1997 realizzammo insieme una cartella ricca di sette acqueforti, per le edizioni di Giacomo e Mario Adda, Ancora un anno, accompagnata da scritti autografi di alcuni poeti e narratori italiani: Lino Angiuli, Tano Citeroni, Raffaele Crovi, Michele Prisco, Paolo Scandaletti e Carlo Sgorlon. i piace riportare uno stralcio dalla mia prefazione alla cartella:
“Sette scrittori e un pittore raccontano lo scorrere del tempo, da un anno a un altro. Osservare la fuga dei giorni comporta sempre una riflessione esistenziale, il contrasto tra eternità e storia, tra finito e infinito, la meditazione sulla fine che si accosta ad ogni mutamento di stagione, sul senso stesso del tempo, sul nulla. I riferimenti letterari alle Parche o al Venditore di Almanacchi diventano forse costanti in coloro che si accostano al tema.
E in questa ottica si pongono gli autori della plaquette che Benito Gallo Maresca ha voluto accompagnare con una serie di incisioni dedicate alle stagioni dell’anno, ai loro doni, alle loro promesse. Un autore passionale e lirico, Gallo Maresca, legato a una figurazione neoimpressionista non scevra da un velo di inquietudine”.
La cartella, tirata in un centinaio di copie ebbe molta fortuna, tanto che avevamo progettato una seconda opera che non ebbe mai prosieguo per vicende legate a quegli anni.
Leonardo Mancino era un ermetico impegnato politicamente nel Partito Comunista, aveva un atteggiamento guascone e anarcoide, un uomo che aveva dedicato saggi a Scotellaro e ad Albino Pierro e che frequentava molti poeti e pittori sia delle Marche, la sua regione, sia della Puglia e della Basilicata. Ricordo i suoi rapporti con Ginetto Guerricchio, Valeriano Trubbiani, Renzo Vespignani, e in Puglia con Antonio Laurelli, Matteo Masiello e il gruppo de “La Vernice”. Mentre in poesia era molto amico di Elio Filippo Accrocca e del gruppo romano di Portonaccio, dirigeva una collana di poesia per Lacaita nella quale aveva pubblicato versi di Carlo Francavilla, un poeta che aveva vinto proprio con un libro de “I Testi”, Le terre della sete, un premio Viareggio, e raccolte di Mario Dilio, Giorgio Barberi Squarotti, Vittore Fiore, Giorgio Manacorda, Biagio Balistreri.
Mancino aveva tenuto a battesimo Benito, accompagnandolo in alcune personali presso la galleria “La Vernice”, aveva scritto anche epiche presentazioni in catalogo e aveva fatto da tramite tra Benito e questi poeti.
“La Vernice” era in piazza Massari, a Bari, la gestivano Benito e Antonio Bibbò, Piero De Giosa, ebbe alterne vicende e dopo una breve chiusura rifiorì come “Nuova Vernice”, contò oltre i due capostipiti, Antonio Laurelli, Carlo Fusca e altri e si pose prevalentemente lo scopo di dare spazio ai nuovi artisti pugliesi. Sotto Natale si usava realizzare collettive del piccolo formato a cui partecipavano artisti di varia levatura e provenienza. E si alternavano collettive di giovani pittori e personali di artisti affermati. Erano di casa Adolfo Grassi, Beppe Labianca, Matteo Masiello, Leo Morelli.
Benito e Antonio erano entrambi campani, di Castelvetere di Benevento il primo, di Boscotrecase il secondo, insegnavano entrambi nell’Istituto d’arte di Bari, città nella quale avevano messo su famiglia.
Bibbò era prevalentemente scultore, e seguiva Degas. Erano gli anni in cui Bari contava molte gallerie, un pubblico appassionato d’arte e molti atelier in cui operavano i pittori Raffaele e Ciccio Spizzico, Vito Stifano, Guerricchio e dove approdavano d’estate Onofrio Martinelli, Domenico Cantatore, Roberto De Robertis, Pino Pascali, Vincenzo Ciardo, e dove stavano emergendo Michele Damiani, Labianca, Elia Canestrari, Rose Marie Sansonetti, Franco Granito, Iginio Iurilli, Gennaro Picinni, Renato Nosek, Lino Sivilli, Franca Maranò, gli artisti della quinta generazione.
Due elementi caratteriali non cambiavano mai in Benito, la tenerezza e la vitalità. Nonostante gli acciacchi, gli interventi chirurgici subiti, gli anni che avanzavano, non perdeva l’irruenza con cui fin da giovane aveva seminato il colore, la passionalità nel dipingere, nell’accogliere gli amici e partecipare alla vita. Affettuoso e sorridente, i capelli neri e scarruffati, tempestoso negli atteggiamenti, pronto a lamentarsi della salute e intanto a mostrarti le diecine di opere piccole e grandi che produceva in un febbrile e quotidiano lavoro, ritagli come francobolli che nascevano a getto continuo, e tele giganti ammonticchiate sui mobili dello studio, tra gli scaffali, contro i muri. Lo studio e la mansarda del giardino erano invasi dai dipinti, da cartoni già finiti e tele che aspettavano il pennello, da montagne di fiori secchi, cardi, bottiglie, suppellettili, libri e da pastelli e oli sparsi sulle sedie, sui cavalletti, sui divani, ad asciugarsi. Tutto sepolto dalla casualità, in un terrore del vacuo, della geometria, del brillante e dell’ordine. L’abbandono come metodo.
Guai a chi accennasse a mettere ordine nel suo mondo. Tutto era utile per dipingere dal vero, ma un vero sepolto, moribondo, fatto per ispirare più che per essere riprodotto, per offrire qualche legame con la memoria del mondo esterno che il pittore frequentava sempre più di rado. Benito Gallo Maresca era il maestro degli oggetti dimenticati, delle nature morte impolverate e ingrigite dal tempo. Procedeva per periodi, un tempo dedicato agli strumenti musicali a fiato, un tempo per i cardi, i girasoli e i fiori secchi, uno per le marine abitate da bagnanti, uno per processioni, un altro per modelle e ballerine, uno per pulcinelli o per distese erbose che raccontavano la murgia o i dirupi della gravina o le distese di maggesi che circondavano la sua campagna di Ruvo. Dipinti a volte monocromi, altre volte bui o soleggiati, ma mai resi con colori squillanti, tutto per ottenere un tempo sospeso sotto un cielo lattiginoso, ovattato dal grigiore del tempo.
Era nato a Boscotrecase, nella cintura vesuviana e forse per questo amava la natura, la tradizione del dejeuner sur l’erbe. Ricordava la sua infanzia, bella e difficile, tra la guerra e le carenze di una famiglia numerosa. Doveva seguire il padre nel lavoro di addobbatore di chiese, salire a diecine di metri per sistemare cadute di stoffe, dipingere muri, collocare cornici di gesso. Bisognava arrampicarsi e con difficoltà trasformarsi in trapezisti, sempre lìllì per perdere l’equilibrio, timoroso di mettere un piede in fallo, perché a lui “non stava l’aria” e l’altezza gli causava capogiri. Perciò il padre lo aveva allontanato da quel lavoro, gli aveva permesso di seguire una scuola d’arte e ciò da cui era attratto, la pittura, da studio o en plain air. Mi raccontava l’incontro con Vasco Pratolini, suo professore di lettere. Pratolini fumava come un turco e ogni tanto, quando sentiva i passi del preside, prima ancora di sentir bussare alla porta nascondeva la sigaretta in un cassetto. Una volta aveva quasi provocato un incendio.
“Nessuno di noi allievi era consapevole di trovarci di fronte a un genio della letteratura. Perché nessuno leggeva”.
Ma ricordava anche le lezioni di Brancaccio, Chiancone, Striccoli, la seconda generazione degli impressionisti napoletani, divisi tra la Scuola di Resine e quella di Piedigrotta.
Che meraviglia la Campania, la costiera e i paesi dell’area sub vesuviana, con gli altri gruppi di Posillipo e dei Campi Flegrei, con ciò che restava della scuola di Raffaello Ragione, di Giuseppe Casciaro e Di Rienzo o del cubismo di Emilio Notte. Pure nella ricostruzione di una civiltà offesa dalla guerra, c’erano i momenti indimenticabili delle gite fuori porta, le scampagnate nel circondario di Boscotrecase, i pranzi all’ombra dei frutteti, le scarpinate sul Vesuvio, con una famiglia allegra e caciarona e con gli amici. Tutto questo aveva trovato asilo nella sua prima pittura, nelle scene di merende sotto pergolati di uva e di frutti, in un pomario ideale, che si è tramandato anche nella maturità, un eden che non lo ha mai abbandonato, dapprima come immagine del suo2 non – realismo e della rivisitazione dell’impressionismo, poi come memoria di una giovinezza bella e perduta.
Ad osservare bene quelle opere senti che il vero soggetto è il silenzio, la calma di un mondo avvolto nel limbo della mente, un mondo “pallido e assorto”.
Questa malinconia della memoria arrivò abbastanza presto, con l’insegnamento e la partenza per Milano, città dove cominciò a frequentare gallerie importanti e dove si dedicò alle prime mostre. Ancora incerto tra astrattismo impressionismo cubismo espressionismo. Era in formazione e in movimento.
Ma un supplente deve rispettare le chiamate dei Provveditorati ed ecco la possibilità di rientrare al sud, accettando un insegnamento a Bari. Fu la stagione in cui fiorì l’amore per Mariapia, una pittrice molto delicata e poetica del cui afflato umano e per la delicatezza, Benito non ha mai smesso di tessere lodi. Per la dedizione con cui ha accompagnato la sua esistenza di artista distratto dal colore.
La città era in forte espansione urbanistica e demografica, i poeti come Davide Lopez e Antonio Nitti celebravano un “mondo nuovo” che dai 15.000 abitanti di inizi Ottocento stava salendo verso gli attuali 400.000, la città dove erano nati il Liceo Artistico e l’Istituto di Belle arti dopo l’Università e dove “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il quotidiano della regione, seguiva la vita degli artisti attraverso il suo critico ufficiale, Pietro Marino. A cui si sarebbero aggiunte negli anni le attenzioni critiche di Pietro De Giosa che scriveva sulle pagine di “Puglia” e quelle di Vito Cracas e di una folta schiera di esperte d’arte, Christine Sperken, Clara Gelao, Antonella Marino, Santa Fizzarotti, Luciana Zingarelli, Anna D’Elia.
Pietro Marino reagiva al provincialismo seguendo le propaggini del nuovo. Accolse l’arrivo dell’ultimo impressionismo napoletano, con Gallo Maresca e Bibbò in testa, con molta attenzione. Tra “La Vernice”, vecchia e nuova, la “Spirale”, il “Sottano”, “La Rosta due”, “Arte spazio” di Consiglia Bellomo, la galleria “Marilena Bonomo” in Via dell’Arca, “La Panchetta” di Arrigo Atti, “Le muse”, la città di Bari mostrava molto interesse per l’arte. Al punto che ebbero grande fortuna il maggio floreale e un annuale premio “Città di Bari” dedicato alla pittura. Per tutti gli anni Sessanta e settanta Benito si lasciò andare a una doppia forma, un espressionismo dettato dai ricordi della guerra appena finita e dalla memoria della felicità di gioventù e l’impressionismo contagiatogli dai suoi vecchi maestri. Soprattutto fu toccato dalla malinconia sociale di Chiancone, la deformazione delle figure, un macchiettismo alla Daumier, il figurativo di Degas, le campagne di Gauguin, Monet, Manet e quel maestro barlettano, Giuseppe De Nittis, attraverso il quale la Puglia partecipava alla grande festa pittorica di fine otto e inizio Novecento. L’attenzione di Bari per l’arte continuava con le gallerie sorte nel circondario, a Molfetta, a Mola, a Monopoli. Luoghi dove Benito espose più volte e che ancora sono in possesso di sue opere.
Ma io ho sempre pensato che il vero punto di riferimento di Benito fosse Cezanne. Osserviamo i suoi nudi sul mare, non richiamano i corpi abbandonati delle Cinque bagnanti, dell’Orgia o delle Grandi bagnanti? E le nature morte, assortite e malinconiche quanto debbono a un’opera come Natura morta con bottiglia di liquore alla menta? O alla Tenda, caraffa e piatti con frutta? E le sue figure non hanno tanto da dire a un dipinto come il ritratto della Signora Cezanne nella serra o nella poltrona rossa? Un amore immenso e costante, quasi un bisogno di sostituirsi sulla tela e con i colori al grande maestro di Aix en Provence.
La realtà di Benito era la sua realtà, non analitica ma sintetica, abitata da creature poetiche, divertenti, caricaturali, figure dai lineamenti deformati. E ciò che piaceva di quel suo mondo era proprio la reinvenzione delle figure della realtà, immagini che sembravano i prodromi di un fumetto giocoso. Una pittura che conferiva poesia e affrancava Benito dal realismo e dallo stesso impressionismo da cui era partito. In questo c’era uno iato tra la figura umana e le nature morte. Tutte pensierose le sue modelle, come sospese nella domanda sulle ragioni della vita o sugli eventi del quotidiano. Spesso nude e tuttavia caste, perché trasferite in un mondo fantasioso e tradotte in pupi da sogno. Il pittore amava osservare anche la nudità filtrata attraverso la propria mente deformante, senza interferire.
Mentre la famiglia cresceva e due belle bambine venivano a tenergli compagnia, Benito perseguiva un doppio binario, uno lo portava alla malinconia della memoria, l’altro alla gioiosità del presente. Nacquero tante mostre, al “Laboratorio delle arti” di Mola, alla “Vernice” di Bari, ad Altamura, alla “Scaletta” di Matera e a Napoli e poi importanti esposizioni a Parma, alla “Gianferrari” di Milano, a Rovigo. Ma non posso dire che Benito fosse assillato dal narcisismo o dalla voglia di emergere. Per esempio, Gianferrari gli offrì di restare a Milano, a spese della galleria, per diversi giorni, allo scopo di farlo incontrare con giornalisti e critici d’arte. Benito ci restò appena una notte, come spinto da un bisogno di nascondersi e di rientrare immediatamente a casa. e tornare alla sua dimensione quotidiana.
QQQ
Questa semplicità di animo e il poco legame alla vanagloria lo si videro quando gli toccò visitare frequentemente la masseria di Ruvo che gli era venuta in eredità dai suoceri. Quasi dimenticò gli studi di Bari. Era attratto dalla natura, dai ciliegi appena piantati, dai meli, dalla ristrutturazione del fabbricato, un’antica masseria a due piani.
Si scopriva lui stesso contadino mancato e andava su e giù tra Bari e la periferia della città di Cantatore. Dove osservava potatori e innestatori, approfittava lui stesso per mettere a dimora le piante, per innaffiare, raccogliere i primi frutti e tra un lavoro e l’altro per disegnare e dipingere case di campagna e filari di frutta e verdura. Un gusto bucolico che gli ricordava gli anni di gioventù.
E intanto coltivava i rapporti col pittore Antonio Laurelli, un astrattista molisano trasferitosi a Modugno, sempre disponibile e collaborativo nell’aiutare Benito in faccende domestiche e di ricerca di utensili, soprattutto negli ultimi tempi, quando l’età aveva irrigidito i suoi movimenti e con il cappuccino padre Ferdinando Luciano Maggiore, bibliotecario del Convento di Santa Fara e con i medici Nino Lamorgese e Dino Palmieri, collezionisti e appassionati di pittura e amici di vecchia data. Si vedevano una sera a settimana in ristoranti sempre diversi, da Pierino l’Inglese o da Orazio a Monopoli, da Zia Teresa a Torrammare e costruivano una sorta di boheme allegra caciarosa spensierata. I due medici usavano portarsi dietro dei fogli che Benito mostrava di non voler affrontare ma che ogni volta scarabocchiava sul momento. Perché le sue mani non riuscivano a starsene inoperose. Era ciò che accadeva in ogni occasione di attesa, come quando si ricoverava per qualche indagine clinica. I medici che lo ebbero in cura dicevano che le infermiere gli passavano sempre manciate di fogli bianchi e un pennarello e Benito partiva con la mano, in attesa del suo turno, in disegni di invenzione. Come bisognoso di allargare l’area del mondo creato con moltitudini di figure, cani uccelli fiori donne ragazzi. Non stava mai fermo e alla fine aveva riempito di disegni le mani di tutti. In una sorta di festa collettiva. Non ne faceva mai una questione economica, era felice di tornare utile a qualcuno e di continuare a riempire il mondo di nuovi soggetti. E a ristorante faceva lo stesso. Ricordo le belle fughe che facevamo ai “Due ghiottoni” o alla “Taberna” di Carbonara a chiusura delle personali. E ricordo a questo proposito un viaggio a Napoli, dove facemmo visita a Michele Prisco, che per Benito intravvedeva e poi a Boscotrecase, presso una delle sue sorelle che aveva preparato un succulento pranzo a base di pesce stocco. Benito era molto amato dai miei amici scrittori, e non dimentico le feste che gli facevano Tano Citeroni, Raffaele Crovi e Gino Montesanto, scrittori che venivano annualmente da noi, richiamati dal Premio di narrativa “Città di Bari”.
E con identica semplicità stava al gioco delle ironie. Accettava il gioco di Citeroni che apprezzava di Benito i mezzitoni e che diceva di trovare in lui vari modi di riempire le tele e trattare le figure, con grandi assembramenti di bagnanti e di pellegrini, con creature solitarie in posa e bambini ruzzanti. E non sto a dire le battute ironiche che si scambiavano lui, Palmieri e Lamorgese a proposito del modo in cui l’artista e il medico si pongono di fronte al corpo femminile e che si chiudevano con questa constatazione scherzosa di Benito, secondo il quale “Il pittore è innocente perché contempla, si astrae e riproduce, o crea, mentre il medico è sempre presente e uccide il sogno perché ha bisogno di toccare per capire”
Una volta tennero insieme una mostra, Grassi e Gallo Maresca, alla Vernice. Prisco che li presentava, spense il suo Tiparillo, prese la parola e ironizzò dicendo che si trattava di una mostra storica, perché eravamo riusciti a mettere insieme Adolfo e Benito. E fu una risata generale che Gallo Maresca più tardi, proprio alla “Taberna” chiuse con un disegno in cui presentava una testa pelata e una creatura dai baffetti inequivocabili.
Alle campagne vesuviane si erano intanto sostituite la pianura pugliese, le passeggiate verso la proprietà agraria di Ruvo e la passione per gli scoscendimenti di Gravina, dove Benito aveva in Pino Santulli un allievo molto vicino alla sua pittura. Un giovane bravo e sfortunato che non è riuscito a godersi la famiglia e la propria fortuna pittorica. Rileggo nelle opere di quegli anni un’ascendenza franco-tedesca, le deformazioni della figura, un gusto del colore avvelenato che assedia il realismo napoletano e va verso i toni smorzati di Morandi. Come ossessionato dalla deperibilità delle cose, da un mondo che si fa inconsistente: un sogno, secco e moribondo. Fiori mele granati ricci limoni secchi e privi di vita e bottiglie piatti caraffe invadevano lo studio, ripeto, un mondo di oggetti resi irreali dal tempo, un paese che nella polvere si faceva luogo di ricordi. Toglieva la brillantezza e spargeva grigiore. La polvere e il tempo rendevano tutto esangue. Il colore dava consistenza alla vita, ma lui aveva bisogno di rappresentare un mondo destinato al silenzio, in una poderosità fantasmagorica e tuttavia dolente e memoriale. Un’atmosfera decadente e di sfinimento. Mi ricordava spesso un aspetto della vita di Morandi, che usava ammonticchiare vetri nel suo studio e impediva a chicchessia di mettervi mano, di spolverare. Un mestiere caro alle inservienti. In questo erano vicini, lui e Morandi, nel bisogno di affogare gli oggetti di casa e le nature morte nella coltre di polvere. Oggetti dimenticati e tali che si vedevano smorzare la luminosità e la brillantezza nel grigiore dell’abbandono. Erano entrambi animati dal desiderio di raffigurare il tempo cristallizzato. Ed era emblematico che Benito non amasse riprodurre i fiori appena colti ma i fiori secchi. Come se amasse la realtà consunta dal tempo.
A questo proposito mi torna alla mente un ricordo del pittore Beppe Labianca rafforzato da quello di una sua allieva, Carmela Andriani. Negli anni dell’Istituto d’Arte, il professor Gallo Maresca, docente di disegno ornato, passava tra i banchi, osservava i disegni degli allievi e ripeteva: “Scurisci Labianca, scurisci Andriani”. Per dare consistenza agli oggetti e vestirli di profondità e di tempo passato.
Benito ha attraversato la repubblica del colore con la passionalità dei campani. Ma nel trasferimento, aveva smesso le montagne e si era perso tra le macchie della murgia, nelle campagne dell’agro barese, tra i sassi e le pietre che animavano le tele di Natale Addamiano, aveva incontrato le masserie, le vigne e gli oliveti pugliesi, i colori erano ancora quelli robusti della costiera amalfitana ma si erano rappresi e abbrunati di malinconia. Così le nature morte se non erano le bottiglie di Morandi molto avevano di quelle, perché erano oggetti entrati nello studio da anni e abbandonati, costretti a morire una seconda volta, a impolverarsi,a misurare il tempo con la dimenticanza. Come dire che le figure di Benito riproponevano il recinto di un mondo svanito.
Entravo dunque nel suo studio e tutto orbitava intorno al cavalletto, collocato al centro della stanza. Era la vecchia casa di sua suocera e lui l’aveva occupata e trasformata nel proprio mondo. Ma Benito perdeva subito la quiete, cominciava a cercare tra i lavori, per mettermi al corrente delle ultime prove, discutevamo per qualche tempo poi tirava fuori una tela e mi diceva “portala a Livia, so che a lei piace la mia pittura”. Era una fontana di affetto.
Erano vuote le voliere sparse per le stanze. Abitate un tempo dai cardellini ora segnavano una stagione svanita. Tutto utile per dipingere dal vero un mondo che era stato. Com’era diversa la bonomia surreale e scherzosa di Benito dalla violenza coloristica ma cimiteriale di certi dipinti.
Ecco, lo sdoppiamento caratteriale era l’elemento che mi colpiva di lui. Allegro e conversatore con gli amici e con i familiari, mostrava una profonda timidezza di fronte al grande pubblico. All’inaugurazione delle sue personali parlava poco, con le mani dietro la schiena si nascondeva tra i visitatori, gli piaceva ascoltare ciò che dicevano delle sue opere, ma taceva, come fosse uno dei tanti spettatori. “Devono parlare i quadri” mi diceva.
Ricordo un episodio che mi pare emblematico del suo carattere. Il 5 giugno 2001 accettò di ritirare a Noci il premio “Tommaso Fiore”, insieme ad uno stuolo di scrittori e pittori provenienti da tutta Italia. Si dormiva nei trulli della masseria “il Barsento”, a pochi chilometri dal santuario di Santa Maria del Barsento e di giorno si girava per i paesi della murgia mangiando mozzarelle e burrate per quello che avevamo battezzato: “Viaggio nel paese delle pietre che parlano”.
Ricordo che mangiavamo ciliegie dagli alberi del giardino e nodini preparati dal casaro in un angolo della masseria. Col pullman ci si spostava per paesi alla scoperta della Puglia. Il tutto era stato organizzato da Piero Liuzzi allora presidente del parco letterario “Formiche di Puglia”.
Alla spicciolata arrivavano gli ospiti. Da Bologna Tinin Mantegazza, pittore, scenografo, amico di Dario Fo e con lui la sua compagna, Velia, regista del Piccolo di Milano. Ma arrivava da Roma anche Predrag Matvejevich, con la sua voce ispirata e sottile, le sue piccole difficoltà ad usare l’italiano. Intanto tutti provavano a sistemarsi nella fila di trulli, tra le incertezze che presentava un posto come quello, fatto per toccate e fuga più che per soggiornarci. Il pittore Michele Damiani era giunto da Bari con la moglie Marcella, aveva familiarizzato con Matvejevich e parlavano fitto dell’ultimo volume di Predrag, sul pane, raccontato nelle valenze antropologiche e culturali.
Al primo giorno di festa, sulla piazza centrale di Noci si radunarono i gitanti. Alberto Bevilacqua, con la sua giovane compagna, Michela Miti e poi Maria Pia e Benito Gallo Maresca, Domenico Fiorelli e il decano dei pittori pugliesi, Raffaele Spizzico, insieme a Adolfo Grassi ed a Giovanna e Vito Matera e Damiani. L’unico a dare forfait era stato Alberto Sughi, per ragioni di salute. Si erano aggiunti poi Peppo Pontiggia e Stanislao Nievo, il pittore Pedro Cano e Raffaele e Luisa Crovi e Tinin e Velia Mantegazza. Furono giorni incantevoli e unici nella nostra vita.
Ciò che ricordo di Benito è che quando lo chiamarono sul palco, rifiutò categoricamente di parlare, quasi tremava, non riusciva a restare in piedi sul palco e chiedeva ardentemente di consegnargli il premio senza porgli domande. Era refrattario alle interviste e molto emozionato.
A testimoniare sulla sua pittura chiamarono me e spiegai che Benito amava dipingere il sonno delle cose, della vita, dei paesaggi. Da poco aveva concluso una serie di dieci opere sul tema del brigantaggio. Un argomento che si era concluso da tempo.
Un paio le aveva inviate a una collettiva presso la pinacoteca di Potenza. Si trattava di due oli, mentre per le altre aveva utilizzato delle pagine di quotidiani incollate a un supporto di masonite. Lo scopo era raffigurare le azioni di guerriglia come elementi di una cronaca sanguinaria e violenta che si era consumata giorno dopo giorno nelle campagne delle provincie meridionali. Alcune tavole raffiguravano il campo dei briganti, con donne e bambini intorno a tavolate di cibi. Mi parvero una riproposizione della sua giovinezza sul Vesuvio, ma anche una ripresa dei temi sociali raffigurati dal suo amato Chiancone. I cappelli appuntiti, i volti dei bambini come lazzaroni sparsi tra i sedili e un panorama di rocce e di alberi. Ma proprio quel panorama che non riproduceva più i pomari e gli aranceti della sua pittura consueta spiegavano la drammaticità del momento e la difficoltà di quell’esistenza. Alcune tavole raffiguravano invece dei patiboli con diecine di impiccati e altre erano ritratti di soggetti dai volti stirati, volti contadini, affilati e smunti che non avevano nulla della finezza borghese dei pulcinelli, delle modelle e dei tanti bagnanti che popolavano i suoi quadri abituali. Erano dipinti popolareschi, quasi tavole di musicanti girovaghi, molto animati, diversi dalla monotonia della vita metropolitana, fatta di interni con figure di condòmini pasciuti o di belle e procaci modelle dai volti non molto definiti, dai corpi pupazzati e che si allontanavano da ogni realismo. Erano storie epiche, diverse dagli harem silenziosi dove alitava un erotismo contenuto.
Alla collettiva di Potenza era seguita una trasferta a Pietragalla, dove parlammo di brigantaggio e inaugurammo una delle tante sessioni della collettiva sul tema dei banditi. Benito era capitato a pranzo di fronte a un docente di storia moderna di Milano, il professor Mozzarelli. Avevano abbellito il tavolo con un piatto di peperoncini piccanti, belli rossi e lucenti e Mozzarelli si era incantato. Li guardava rapito, come non avesse mai visto quegli ortaggi. Benito che sedeva tra me e Nino Lamorgese colse quello stupore e suggerì al docente di non toccare, di comportarsi come il pittore, che guarda e non tocca. Disse: “Professò, questi sono come la Medusa che incanta e rischi di restare pietrificato se la fissi”.
Poi ci eravamo assentati per qualche attimo e al ritorno avevamo trovato Mozzarelli mezzo morto, senza fiato e con gli occhi che gli scoppiavano dalle orbite. Benito aveva subito intuito, gli aveva passato del pane e un bicchiere di vino e gli aveva ribadito: “Professore, le avevo raccomandato di non toccare, di fare come il pittore che osserva e riproduce, invece lei che ha fatto? Ha divorato un intero peperoncino. Lei è pazzo. Ci può restare secco”.
Il povero Mozzarelli continuava a soffrire e a cercare aria e acqua, come un pesce che affoga.
Successivamente la mostra passò a Torremaggiore, all’Università di Foggia e a Campomarino.
Al compimento dei miei cinquantasei anni, Benito mi donò una vecchia agenda, era infatti del 1999. Me la donò il 2003 e in quei quattro anni aveva approfittato per disegnare tutto il suo mondo. Si apriva con un cesto di frutta e poi con la data del 18 giugno 2000, un ritratto di Maria Pia seduta in poltrona a Ruvo. Era voluminoso come le agende e per metà ricco di schizzi e disegni fatti con immediatezza e senza ripensamenti. C’era tutto il suo mondo, un mondo popolaresco di pulcinelli, ballerine, alberi prospicienti il mare, una figlia, forse Magda con in braccio un bambino, galline colorate, olivi, ricci, galline belle pasciute e bambini che erano i suoi nipoti, paesaggi murgiani e frutti. Inchiostri gessetti acquerelli tratteggiavano con rapidità nervosa, si arrischiavano anche in qualche autoritratto. Mi spiegò che era abituato a pensare mentre la mano agiva, a prendere appunti in forma di disegni. Erano i pensieri che sarebbero diventati più tardi dipinti. A vedere le creature di quel diario ci trovi un mondo semplice, quotidiano, un eden ora collocato in un giardino di famiglia ora in un interno di casa borghese e penso sempre alla sua generosità e a un uomo animato da un gusto infantile, bonario, il creatore di un mondo coloratissimo e al cui fondamento, di là dalla bellezza espressa, c’è sempre una velata malinconia.
Come ho avuto modo di ripetere, Benito si portava dietro un dissidio insanabile, la vitalità del carattere e la consapevolezza del tempo che passa. La vita come insieme di luogo vivo e agonizzante, di natura che esplode per bellezza e di seccume, di vitalità frenetica e di abbandono a una moria lenta e progressiva. La forza del presente e l’oblio del passato. Questa è l’immagine di noi, risvegliati dalle gioie dell’alba e affogati nella polvere del crepuscolo, nel buio del tramonto. E in questo chiasso vitale e nel silenzio che ci consuma, nella penombra improvvisa, nelle pause e nel frastuono continuo dei sentimenti si svolgevano l’esistenza e la creatività sua e nostra. Un tempo condotto tra maschere di un teatro che per Benito Gallo Maresca era il mondo della provincia, fatto di scene familiari, di confidenze materne, di affetti filiali e paterni, di rapporti amichevoli e di vicinato affidati alla festosità del quotidiano e all’acquario del tempo.
Benito Gallo Maresca si è spento in Bari il 24 giugno 2020.
Raffaele Nigro
http://1995-2015.undo.net/it/mostra/1085208/10/2010
Benito Gallo Maresca
GALLERIA SPAZIOSEI, MONOPOLI (BA)
80 voglia di vivere con la pittura. Per gli 80 anni del pittore, Mina Tarantino ha curato un’ampia antologica con il meglio della produzione di Gallo Maresca.

COMUNICATO STAMPA
La galleria SPAZIOSEI di Monopoli promuove dal 9 ottobre al 13 novembre 2010 la mostra personale del maestro Benito GALLO MARESCA, un evento culturale che conferma l’impegno e la sensibilità dell’Associazione per la cultura e l’arte: 80 voglia di vivere con la pittura Benito GALLO MARESCA, nato nel 1930 a Boscotrecase (Na), dal 1956 vive a Bari.
È stato titolare di cattedra di discipline pittoriche presso l’Istituto d’Arte e, fino al 1989, presso il Liceo Artistico di Bari. Con Bibbò, De Robertis, Spizzico e Stifano, ha dato vita alla galleria d’arte “La Vernice”, contribuendo in modo determinante, con una attività più che quarantennale, alla vita artistica e culturale della città di Bari. Vincitore di numerosi concorsi pubblici, ha realizzato opere artistiche per scuole, ospedali e palazzi comunali; ha ricevuto molti premi e le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
Nel periodo 1982-86 ha ricoperto l’incarico di consulente per la valutazione di opere d’arte presso il Ministero dei Beni Culturali. La mostra, a cura di Mina TARANTINO, realizzata in occasione degli ottant’anni del maestro Gallo Maresca, è presentata dal critico d’arte Santa FIZZAROTTI SELVAGGI, che di lui scrive: «Benito Gallo Maresca ha vissuto con e nella Pittura, sua compagna fedele, suo ineludibile Oggetto d’amore. L’artista, nelle cui vene scorre il colore, e dunque l’emozione, ben rappresenta la tradizione pittorica di Puglia, sua terra d’adozione, del Mezzogiorno, del Mediterraneo: ma insieme alla passione ha sempre lasciato emergere una ragione altra dal labirinto dei pensieri, da quel luogo erotico che nelle arti svela il sogno dei sogni. Cantore di cose e paesaggi, coltiva dentro di sé la giovinezza eterna tipica dei Maestri nel cui sangue scorre il sentimento oceanico dell’amore.
Le sue opere evocano sensazioni perdute, trovano nella matericità della pittura effetti elegiaci che ci riconducono ad una poetica dalle potenzialità incommensurabili. Non a caso Raffaele Nigro così del Maestro ha scritto: “Soltanto il colore rende le cose esistenti, depositate come sono in una cesta, su un tavolo, nel riquadro di un fazzoletto, proprio come i nomi danno asilo nel mondo degli uomini, un mondo fatto di dialogo e di parole”. Benito Gallo Maresca, attraverso il colore, incontra il suo vero Sé, aperto all’incontro con l’Altro.
Nella mostra aleggia impalpabile il Fato, che risulta essere superiore agli Dèi, una chiarezza quasi illuministica che consente di percepire un insieme di voci, quelle della nostra gente e della nostra quotidianità dolente, che si fanno anelito di speranza. Il taglio compositivo è austero, privo di ogni superfluo orpello, mentre appare carico di un silenzio colmo di drammaticità. La magia della pittura disvela un verso di Goethe ”Tutto ciò che passa non è che immagine”. È questa la minima parte di una verità a noi sempre irraggiungibile che nasconde in sé l’idea di una catastrofe. A tal proposito non mancano le esperienze informali, quali testimoni che solo il saper “fare” pittura può condurre alle più ardite sintesi.
Una gestualità che induce Benito Gallo Maresca a concedersi alla terra, al cielo, alle acque, alle nuvole, agli arbusti fioriti dei nostri boschi, che egli sente partecipi della vicenda umana. Di qui gli accenti fauves che permeano le Sue opere. Il gruppo dei Fauves comprese pittori quali Matisse i cui cromatismi hanno aperto nuove intuizioni sul dipingere, sulla luce generata dall’accostamento di colori puri.
E in Gallo Maresca il significato dell’opera coesiste e scaturisce dalla forma, dal colore, dall’immediatezza della gestualità. La narrazione di Benito Gallo Maresca si snoda lungo i versanti di una profonda ferita che paradossalmente unifica le parti, luoghi impossibili, epoche diverse. Ma in realtà lo sguardo coglie l’essenza più segreta delle rappresentazioni pittoriche dominate da figure allegoriche e paesaggi densi di plasticità. Questo è il motivo che rende la mostra un percorso misterioso di sapienza, di respiri ineffabili, di commozioni che, tese al massimo di un lirico realismo, sollecitano il nostro cuore, la nostra mente e i nostri sensi.
Le immagini si accendono di tensioni: il segno è una meravigliosa linea di caduta che tradisce la malinconia dell’artista. Le contraddizioni dei cieli smaltati generano la voglia di svanire nel mondo delle visioni, tra le plaghe sconosciute dell’universo. L’obliquità dei tagli riconduce alla riflessione intorno al trascorrere del tempo, a quella nostalgia che tesse la tela dell’arte. Ricordi, memorie, avvenimenti lontani costruiscono le trame narrative di opere che si rivolgono ad una metaforica Stella polare, intima guida silenziosa e sfuggente ma al medesimo tempo sicura per i naviganti nel mare dell’essere. Per Gallo Maresca la figura umana è questa Stella polare. Immagini di donne concrete, carnali e al medesimo tempo virtuali e lontane, ma sempre presenti, si distendono languide al centro della scena dell’arte. La Donna, la Madre, la Madre –Terra, le radici mai dimenticate… La luminosità dei colori rende suggestive le opere che si aprono sulle pareti della galleria, mentre al limite di tempestosi orizzonti si liberano angosce e reminiscenze.
L’assillante rapporto di essere e non essere, del giorno che volge al tramonto, in attesa dell’alba, trova un adempimento, quasi in termini heideggeriani nell’impensabile luogo dove anche la morte può vivere: la pittura diviene il frutto di complesse elaborazioni del profondo. La memoria trattiene gli istanti; il corpo si fa immagine, vibrazione infinita, evocatrice di atmosfere irreali.
È la cifra del nostro “essere al mondo” che riempie di poesia l’elemento pittorico mentre costruisce la leggenda dell’arte, lo specchio magico del tempo. La drammaticità delle scene genera effetti tridimensionali e l’artista viaggia fra i desideri della ”speranza” rimasta sul fondo del vaso di Pandora, richiuso forse troppo in fretta… Mario Sansone così scrive dell’opera di Gallo Maresca: “La realtà non è mai vista con lo stupore delle cose imprevedute, mai possedute nei suoi limpidi contorni o nelle sue tragiche dissonanze, ma è colta – e accettata – nel suo farsi, collocata in un ritmo che ritiene sempre qualcosa di incompiuto e quasi provvisorio”. Questo è il senso del linguaggio delle arti. Nulla è casuale e la progettazione si affida al dominio del visuale che nella materia incontra l’anima nella sua corporeità.
La voglia di volare sempre più in alto trova la sua realtà nell’incontro quotidiano con l’“amante” che lo ha sempre accompagnato nella vita: “un’amante carnale” fatta di antiche opalescenti memorie che si spiritualizzano tra le scene dell’arte. ”Impassibile, l’anima riposava, guardandosi lottare” scrive Arjuna, e i lavori di Gallo Maresca rappresentano la Natura che dolorosamente diviene, si trasforma mentre trascende sé stessa. La tecnica, non a caso, oscilla fra equilibri e squilibri, fra i due punti estremi che si inscrivono in un sospiro che è respiro: vivre…je respire et je vois. L’Artista celebra il suo amore segreto, questo Amore ha un nome: la Pittura.»